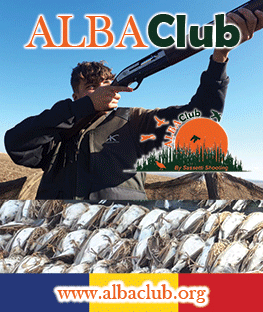IL ROCCOLO
La storia del roccolo è la nostra storia, racconta di privilegi e fame, di ingegno e povertà, di senso del bello e acume d’intelletto. Essa si spinge molto lontano e pazientemente, come solo gli antichi useladùr sapevano essere, accompagna la povera gente sin dall’epoca della Roma arcaica, culla dell’arte dell’aucupio: la cattura degli uccelli con l’uso di trappole, letteralmente dal latino “avis-capio”.
La carne aviaria era, infatti, già dai Romani fortemente apprezzata, ma dobbiamo attendere il Medioevo perché lacci e reti per la sua cattura fossero sostituiti da mezzi più ingegnosi. E l’ingegno, si sa, nasce dalla necessità di sopravvivere. Proprio in tale epoca, infatti, i feudatari avevano il controllo totale delle campagne italiche, imponendo il loro arbitrio su contadini avviliti al ruolo di servi della gleba.
I grandi possidenti, ebbri di suntuose cacciate a cervi e cinghiali, non permettevano, infatti, che tale nobile selvaggina venisse cacciata da altri nelle loro terre, e alla agente comune, affamata e derelitta, non rimaneva altro, per nutrirsi, che affidarsi alle misere risorse di un’agricoltura ancora troppo poco sviluppata per permettere un sostentamento alimentare degno. E nemmeno l’allevamento di animali rustici e magri era sufficiente per le loro povere tavole.
Tale situazione si faceva ancora più drammatica nelle zone di media montagna, dove né la pastorizia né l’agricoltura potevano fungere da adeguato sostentamento. Così, i feudatari, coscienti di una situazione insostenibile, concessero a questa povera gente di poter almeno catturare la selvaggina minuta che loro, personalmente, non apprezzavano. Così, adesso, stava solo all’ingegno del popolo riuscire ad arricchire la propria tavola con la cattura di questi piccoli selvatici.
E il contadino non era solo ricco d’ingegno, ma ben conosceva i luoghi, la vegetazione, le abitudini stagionali degli uccelli e seppe nel tempo affinare la propria tecnica venatoria. Sino alla costruzione dei roccoli.
Queste strutture, che possiamo senza remore definire delle meraviglie architettoniche vegetali, sorsero soprattutto nell’Italia settentrionale, con un’ubicazione e realizzazione che variava molto a seconda delle tipologie ambientali in cui nascevano.
Se venivano costruiti in alta montagna, difficilmente usufruivano di strutture vegetali vive, dato che le intemperie, la neve e le basse temperature avrebbero potuto in breve tempo ucciderle; inoltre, tali ambienti mal permettevano la nascita e lo sviluppo spontanei di una vegetazione importante. Per questo, i roccoli di montagna erano solitamente costituiti, per la parte arborea, di pali mimetizzati da rami di abete rosso.
Molto più caratteristica era, invece, la vegetazione oculatamente scelta per i roccoli di collina e di pianura che potevano sfruttare alberi vivi quali i carpini bianchi, ricchi di germogli in ogni propria parte e resistenti alle necessarie, numerose potature ; in grado, oltretutto, di mantenere inalterato gran parte del proprio fogliame fino all’autunno inoltrato. 
Il roccolo è, quindi, un’opera muraria e vegetale.
Cuore di questa ingegnosa architettura venatoria è il casello (casel): una specie di torretta avvolta da erbe rampicanti, composta, se completa, di piano terra e due piani, completamente nascosta da alberi di carpino disposti a ferro di cavallo, distanziati qualche metro l’uno dall’altro e alti circa 4 metri.
Il piano terra è un stanzetta definita “stansa fosca”, dove vengono collocati gli uccelli catturati; il primo piano è occupato dall’alloggio del roccolatore che può rimanere pazientemente nel roccolo giorno e notte, silenziosamente.
Il secondo piano è la stanza più importante della struttura, la “stansa dell’useladòr” perché qui si svolge l’effettiva mansione dell’uccellatore: nella sua parete è presente una fessura, “spiunerà”, attraverso cui spiare la presenza degli uccelli sugli alberi, e un’altra apertura, “sborfadura”, per mezzo della quale avviene l’effettiva cattura degli uccelli intrappolati nelle reti.
Il casello è nascosto da alberi che celano reti e pertiche interne (sigaler), per la cattura dei primi uccelli, ed esterne (pasada) per il recupero dei volatili sfuggiti alla precedente cattura. Tutti questi alberi vengono periodicamente ed oculatamente potati per svolgere l’attività di appetibile richiamo e falso rifugio per gli uccelli. Tra essi viene solitamente posizionata una pianta, broca, le cui fronde secche attirano, invece, quei volatili che non troppo amano i fitti rami.
Un richiamo assolutamente interessante, quindi, per tutti i volatili in cerca di ristoro, riparo e frescura, reso ancor più accattivante e irresistibile dal posizionamento di uno zimbello (sambel) su di un’apposita impalcatura, affiancato da numerosi uccelli vivi e legati con spago. Molte, poi, sono le gabbie con i richiami poste fra le fronde e a terra.
L’attesa all’interno del roccolo era sempre lunga e silenziosa; nonostante, infatti la costruzione dell’ingegnosa trappola e lo studio attento dei luoghi di passo, non sempre gli stormi si posavano, messi in allarme dalla loro strabiliante sensibilità o da rumori. Il paesaggio circostante la struttura poteva, almeno in parte, se non smorzare il morso della fame dei roccolatori, almeno pacificare gli animi in attesa.
Quando, fortunosamente, lo stormo sceglieva invece il roccolo come luogo di riposo e si era posizionato nello spazio centrale, dal casello erano improvvisamente agitati “spauracchi” o “battarelli” a forma di falco o racchetta, venivano urlate grida che imitavano quelle degli uccelli in allarme, e gli uccelli scappavano terrorizzati, dritti nella reti predisposte fra gli alberi, potendo sfuggire alle prime, ma non alle successive. Quindi, gli uccelli catturati venivano liberati dalle reti e messi nelle gabbie della stanza fosca.
Così, le povere mense contadine potevano arricchirsi di un cibo proteico e assolutamente vitale per la sopravvivenza.
Il sopraggiungere, nel Settecento, di un maggior gusto del bello, spinse molti nobili a gareggiare nella costruzione di roccoli particolarmente decorativi nei propri parchi: strutture, quindi, non solo , ma anche particolarmente appariscenti per la loro magnificenza, veri e proprie opere d’arte.
L’imboghesimento successivo della società e la decadenza della nobiltà minarono la tradizione del roccolo come architettura d’esterno di pregio, ma nulla tolsero alla sua antica origine: boscaioli, contadini, povera gente fino al primo dopo guerra continuarono ad utilizzarli per il proprio sostentamento, fino a farli divenire, nel tempo, fonte di guadagno e di commercio.
Ad oggi, i roccoli rimasti integri non sono molti e, pur mantenendo intatte struttura originaria e metodologia d’utilizzo, essi servono prevalentemente per studi ornitologici, più raramente per la cattura di soggetti destinati alla cattività.
Sara Ceccarelli